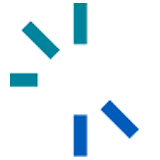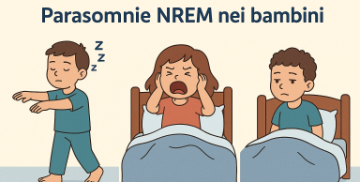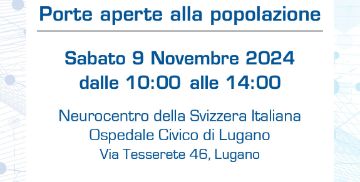Ictus
L’ictus cerebrale è causato da un disturbo della circolazione sanguigna nel cervello. L’ictus è una malattia complessa e pericolosa, che si manifesta con sintomi ad esordio improvviso ed acuto (ad esempio: debolezza di un braccio o gamba, disturbi visivi, difficoltà ad esprimersi, cefalea). Riconoscere precocemente i sintomi di un ictus ed inviare rapidamente il paziente alle cure specializzate in un ospedale dotato di Stroke Center riduce notevolmente i rischi di handicap e aumenta le possibilità di sopravvivenza.
Se sospettato, vengono effettuati in urgenza:
- valutazione neurologica;
- imaging cerebrale (TAC cerebrale oppure Risonanza magnetica Cerebrale) con studio dei vasi sanguigni;
- opportune valutazioni specialistiche per identificare la potenziale causa dell’ictus.
Trattamenti acuti e di prevenzione
L’ictus è una malattia curabile. È fondamentale riconoscere i sintomi e reagire tempestivamente: infatti, quanto più velocemente viene ripristinato l’apporto di sangue, tanto meno le cellule nervose vengono danneggiate o muoiono.
- Trattamento acuto (ictus ischemico): ha come obiettivo la riapertura del vaso occluso (terapia di riperfusione cerebrovascolare); questo può avvenire, in pazienti selezionati, cercando di sciogliere il coagulo di sangue attraverso un farmaco intravenoso (trombolisi intravenosa) e/o rimuovendo il trombo mediante un catetere intra-arterioso (terapia endovascolare).
- Terapie di prevenzione: hanno l’obiettivo di prevenire il ripetersi di ictus nel futuro e sono individualizzate al paziente a seconda della causa dell’ictus e dei fattori di rischio cardio-cerebro-vascolari individuali.